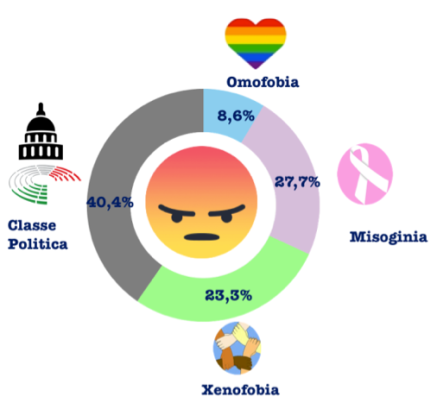C’era una volta il racconto, poi è nata l’arte del raccontare. Lo storytelling viene utilizzato soprattutto da chi ha come obiettivo il comunicare qualcosa o, nel peggiore dei casi, vuole controllare le opinioni altrui. È una tecnica che ha invaso tutti i settori della nostra società, dalla pubblicità alla politica, perché narrare significa “far conoscere”. Come dice Roland Barthes, «il racconto è come la vita».
Come sempre, un esempio di comunicazione politica efficace ci arriva dall’oltreoceano, da Barack Obama, durante il suo discorso ai laureandi della Rutgers University, nel New Jersey (QUI il video e QUI la trascrizione). Un discorso accorato, ricco di stimoli e di significati. Uno speech con uno storytelling avvincente con le seguenti caratteristiche:
– favorisce la connessione emotiva tra chi parla e chi ascolta;
– permette di comprendere anche i passaggi più complessi;
– chiama all’azione (call to action);
– attiva e motiva il pubblico;
– porta il pubblico ad occuparsi della causa (caring of);
– rende il pubblico consapevole;
– favorisce la cooperazione;
– contiene messaggi dal forte significato politico ed emotivo
– sono presenti storie che raccontano identità e trasmettono valori;
– sono presenti storie che incorporano conoscenze tacite;
– è presente una buona dose di ironia.
È un discorso ben strutturato in grado di far comprendere bene i contenuti e le opportunità di attivazione del pubblico. Il discorso, intriso di storie, consigli, aneddoti e anche un po’ di ironia, tocca diversi punti: dai Padri Fondatori al surriscaldamento globale, dal tema della salute alla difesa dei fatti e della scienza contro una cultura che fa della menzogna e dell’ignoranza un vanto.
In politics and in life, ignorance is not a virtue.
It’s not cool to not know what you’re talking about.

Poi, siccome il discorso è rivolto a giovani studenti, cita persino una canzone di Bruce Springsteen che invita a non sprecare tempo, a non stare fermi ad aspettare “il momento giusto”.
A guy named Bruce Springsteen, once sang:
“They spend their lives waiting for a moment that just don’t come”.
Don’t let that be you. Don’t waste your time waiting.
Obama non menziona mai il suo antagonista repubblicano direttamente anche se «il mondo è interconnesso», dice, «non abbiamo bisogno di muri, dobbiamo aiutarci gli uni con gli altri e non sollevare il ponte levatoio e cercare di spingere il resto del mondo fuori», alludendo alla proposta di Donald Trump di costruire un muro tra i confini di Stati Uniti e Messico.
The world is more interconnected than ever before
and it’s becoming more connected every day.
Building walls won’t change that.
Poi invita all’azione incitando gli studenti ad andare a votare, perché è importante avere fiducia nella democrazia e perché i cambiamenti avvengono sempre grazie a semplici cittadini che si interessano e partecipano nel processo politico.
Have faith in democracy. Look, I know it’s not always pretty.
Really, I know. I’ve been living it.
But it’s how, bit by bit, generation by generation,
we have made progress in this nation.
Infine, come ripete sempre alle sue figlie (ecco l’efficace storytelling personale), consiglia agli studenti di non perdere mai le speranze, di non scoraggiarsi, di provarci sempre, di puntare sempre al meglio. Non importa raggiungere la perfezione, dice, ma il successo, grande o piccolo che sia, perché è così che si realizza il progresso in una società e, in generale, nella vita.
I always tell my daughters, you know, better is good.
It may not be perfect, it may not be great, but it’s good.
That’s how progress happens, in societies and in our own lives.
Ricordiamo infine che lo storytelling non funziona in assenza di contenuti, ovvero raccontare storie senza fatti comprovati e contenuti interessanti è un boomerang e gli effetti nell’audience si esauriscono in poche ore e in qualche titolo di giornale. Lo storytelling senza storie è inutile, se non dannoso. Invece un discorso con uno storytelling efficace significa parlare lo stesso linguaggio degli elettori (e non quello degli eletti), significa creare una connessione emotiva con il pubblico ponendosi sul suo stesso piano. È un metodo convincente per trasformare i punti di debolezza in punti di forza, fragilità biografiche o politiche in valori positivi.
Insomma, Obama riesce sempre a proporre racconti che colpiscono, che provocano sentimenti, a esprimere principi e posizioni in modo da sintonizzarsi con il proprio elettorato e condividere con questo tutti i valori della tradizione americana.
Dopo le elezioni presidenziali di novembre Obama ci lascerà, o meglio, lascerà la Casa Bianca, perché quando un presidente lascia il potere, dopo una sconfitta o, come in questo caso, alla fine del suo mandato, «occupa spesso gli anni successivi ad assicurarsi che la propria versione della presidenza corrisponda a quella che sarà ricordata dalla Storia. Senza una storia giusta non c’è né potere né gloria».